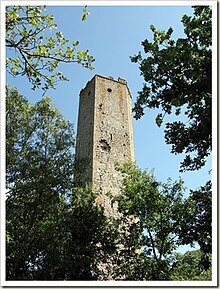La morte
| « La sua fine è stata al tempo stesso simile alla sua opera e dissimile da lui. Simile perché egli ne aveva già descritto, nella sua opera, le modalità squallide e atroci, dissimile perché egli non era uno dei suoi personaggi, bensì una figura centrale della nostra cultura, un poeta che aveva segnato un'epoca, un regista geniale, un saggista inesauribile. » |
| (Alberto Moravia) |
Nella notte tra il 1º novembre e il 2 novembre 1975 Pasolini venne ucciso in maniera brutale: percosso e
travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell'idroscalo di Ostia, località del Comune di
Roma.
Il cadavere massacrato
venne ritrovato da una donna alle 6 e 30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a
riconoscerlo.
L'omicidio fu
attribuito ad un "ragazzo di vita", Pino Pelosi di Guidonia, di diciassette anni, che si dichiarò
colpevole. Pelosi affermò di aver incontrato Pasolini nelle vicinanze della Stazione Termini, e precisamente presso il
Bar Gambrinus di Piazza dei Cinquecento, e da questi invitato a salire
sulla sua vettura, un'Alfa
Romeo 2000 GT
Veloce coupé, per fare un giro
insieme. Dopo una cena offerta dallo scrittore, in una trattoria nei pressi
della Basilica di San Paolo, i
due si sarebbero diretti alla periferia di Ostia. La tragedia sarebbe scaturita
per delle pretese sessuali di Pasolini alle quali Pelosi era riluttante,
sfociando in un alterco che sarebbe degenerato fuori dalla vettura. Lo scrittore
avrebbe quindi minacciato Pelosi con un bastone del quale il giovane si sarebbe
poi impadronito per percuotere Pasolini.
La versione del Pelosi
fu riportata dal telegiornale nazionale RAI la sera stessa del 2 novembre,
violando le norme sul segreto istruttorio e venendo meno al consueto carattere
di asetticità su temi sconvenienti secondo l'allora vigente etichetta
televisiva.
Il racconto
dell'imputato presentava evidenti falle: il bastone di legno marcio non poteva
risultare l'arma contundente che aveva causato le ferite di grave entità
riscontrate sul corpo di Pasolini. Inoltre una colluttazione fra i due era da
escludersi a causa dell'assenza sul corpo di Pelosi di ematomi e simili nonché
di alcuna macchia di sangue della vittima. Pelosi venne condannato in primo
grado per omicidio volontario in concorso con
ignoti e nel dicembre del 1976, con sentenza della Corte
d'Appello, venne confermata la condanna.
Pelosi ha mantenuto
invariata la sua assunzione di colpevolezza fino al maggio 2005, quando, a sorpresa, nel corso di un'intervista televisiva,
affermando di non essere stato l'autore del delitto di Pier Paolo Pasolini, ha dichiarato che
l'omicidio sarebbe stato commesso da altre tre persone. Ha fatto i nomi dei suoi
complici solo in un'intervista del 12 settembre 2008 pubblicata sul saggio
d'inchiesta di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza "Profondo Nero" (Chiarelettere
2009). Ha aggiunto inoltre di aver celato questa sua verità per timore di
mettere a rischio l'incolumità della propria famiglia.
Le circostanze della
morte di Pasolini non sono ad oggi ancora state chiarite. Contraddizioni nelle
deposizioni rese dall'omicida, un "chiacchierato" intervento dei servizi segreti
durante le indagini e alcuni passaggi a vuoto o poco coerenti riscontrati negli
atti processuali, sono fattori che – come hanno ripetutamente sottolineato negli
anni seguenti gli amici più intimi di Pasolini (particolarmente Laura Betti) – lasciano aperte
le porte a più di un dubbio.
A prescindere dai fatti
e dalle reali responsabilità che hanno condotto alla sua morte, la fine di
Pasolini sembra essere emblematica, al punto che alcuni hanno paragonato la sua
morte a quella di Caravaggio:
| « Secondo me c'è una forte affinità fra la fine di Pasolini e la fine di Caravaggio, perché in tutt'e due mi sembra che questa fine sia stata inventata, sceneggiata, diretta e interpretata da loro stessi. » |
| (Federico Zeri) |
Per lungo tempo
l'opinione pubblica venne tenuta all'oscuro sugli sviluppi delle indagini e del
processo, restando del parere di un delitto scaturito in "circostanze sordide".
Due settimane dopo il delitto apparve un articolo della giornalista fiorentina Oriana Fallaci, dove si ipotizzava una
premeditazione ed un concorso di ignoti ma nel frattempo i due protagonisti
erano spariti dalla cronaca. Dieci anni dopo, i mezzi di informazione iniziarono
a sostenere l'ipotesi della Fallaci, dipingendo il Pelosi come "ragazzo di
vita", abitudinario della Stazione Termini, rilevato da Pasolini come esca per
un'eventuale azione punitiva sui quali mandanti si immaginano avversari politici
o malavitosi, ai quali lo scrittore avrebbe fatto dello sgarbo per dei tentativi
altruistici di redimere dalla strada alcuni giovani.
Il film Pasolini, un delitto
italiano, di Marco Tullio Giordana, esce nel
ventennale del delitto. Nella storia dove viene riportato l'iter dell'inchiesta
che demolisce definitivamente la versione difensiva del Pelosi, emergono
testimonianze ad indicare un'estraneità del giovane dall'ambiente della
prostituzione maschile.
A trent'anni dalla
morte, assieme alla ritrattazione del Pelosi emerge la testimonianza di Sergio Citti, amico e collega
di Pasolini, su una sparizione di copie dell'ultimo film Salò e su un
eventuale incontro con dei malavitosi per trattare la restituzione. Sergio Citti
morirà per cause naturali alcune settimane dopo.
Un'ipotesi molto più
inquietante lo collega invece alla "lotta di potere" che prendeva forma in
quegli anni nel settore petrolchimico, tra Eni e Montedison, tra Enrico Mattei e Eugenio Cefis. Pasolini,
infatti, si interessò al ruolo svolto da Cefis nella storia e nella politica
italiana: facendone uno dei due personaggi "chiave", assieme a Mattei, di Petrolio, il
romanzo-inchiesta (uscito postumo nel 1992) al quale stava lavorando poco prima
della morte.
Pasolini ipotizzò, basandosi su varie fonti, che Cefis alias Troya (l'alias romanzesco di Petrolio) avesse avuto un qualche ruolo nello stragismo italiano legato al petrolio e alle trame internazionali. Secondo autori recenti e secondo alcune ipotesi giudiziarie suffragate da vari elementi, fu proprio per questa indagine che Pasolini fu ucciso. Il 1º aprile 2010, l'avvocato Stefano Maccioni e la criminologa Simona Ruffini hanno raccolto la dichiarazione di un nuovo testimone che potrebbe aprire nuove piste investigative.
Pasolini ipotizzò, basandosi su varie fonti, che Cefis alias Troya (l'alias romanzesco di Petrolio) avesse avuto un qualche ruolo nello stragismo italiano legato al petrolio e alle trame internazionali. Secondo autori recenti e secondo alcune ipotesi giudiziarie suffragate da vari elementi, fu proprio per questa indagine che Pasolini fu ucciso. Il 1º aprile 2010, l'avvocato Stefano Maccioni e la criminologa Simona Ruffini hanno raccolto la dichiarazione di un nuovo testimone che potrebbe aprire nuove piste investigative.
Interessante anche l'opinione di uno dei leader
storici del movimento gay in Italia, Franco Grillini. Grillini accusa la
sinistra italiana di non aver accettato l'omosessualità di Pasolini e di aver
creato una teatrale mistificazione sulla sua morte attribuendola a picchiatori
fascisti che agivano nell'ombra. In realtà la morte violenta di Pasolini è
simile a tante altre vicende di sangue che hanno viste come vittime omosessuali
italiani costretti a vivere nell'ombra la propria sessualità e a contatto col
sordido ambiente della prostituzione maschile. Ha dichiarato testualmente
Grillini: “Molti sostennero che c'era una pista politica di estrema destra
nell'assassinio di Pasolini, ma è una tesi che non ha avuto finora riscontri
probatori e che non è mai stata molto convincente” continua ancora il presidente
onorario di Arcigay, “Più semplicemente vale per Pasolini quello che è successo
a molti altri gay: alcuni ragazzi di vita colti da un raptus omicida non
predeterminato, o che volevano dare una “lezione” ad un gay che li frequentava,
hanno finito per uccidere il compagno di una serata”. “La riapertura della
discussione attorno alla morte di Pasolini dovrebbe essere l'occasione, anche
per tanta parte del mondo politico e culturale italiano, per riflettere sul
fatto che nel nostro Paese si poteva, e ancora succede, morire perché si era e
si è omosessuale”.
Pasolini riposa nel
cimitero di Casarsa della Delizia (PN).